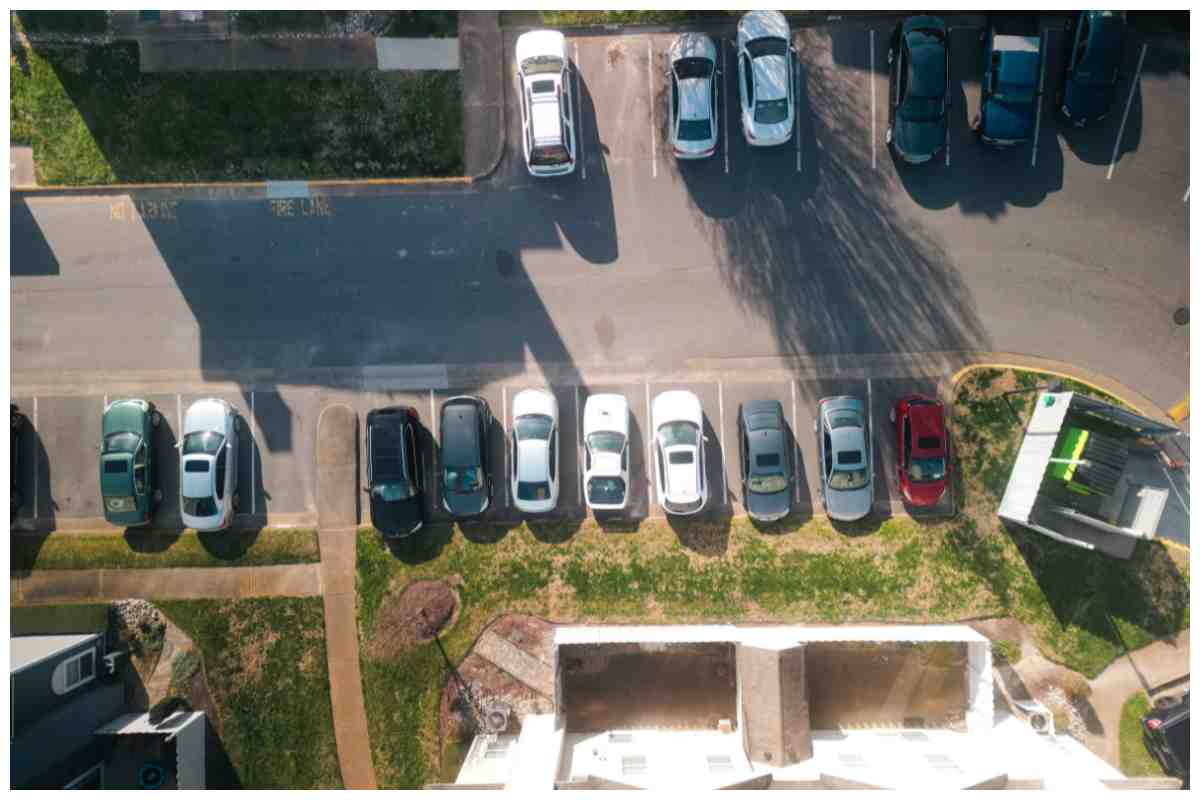Dalle aziende di Stato alle privatizzazioni: acciaio, ritorno allo Stato, il ciclo si chiude. La parabola del liberalismo economico in Italia. Dopo la privatizzazione dell’acciaio, incontrai un noto prelato genovese che mi dichiarò: “Vede dottore, nel reparto che prima occupava venti addetti oggi ce ne sono dieci e la produzione giornaliera è aumentata. Che bravo imprenditore quel Riva”. Gli risposi a caldo: ”Caro monsignore, i dieci operai in esubero sono quelli che ha raccomandato la Curia”. A distanza di circa trent’anni, i principali impianti siderurgici italiani ritornano allo Stato.
Mi sono sempre domandato per quale ragione i sindacati, che occupavano la fabbrica quando l’imprenditore pubblico licenziava un solo operaio, avevano finito per accettare i drastici ridimensionamenti di personale decisi dai nuovi “padroni”.
La giustificazione dei governi dell’epoca è stata che l’Europa aveva introdotto l’economia di mercato: le imprese non concorrenziali dovevano essere chiuse o privatizzate. In altri paesi europei, si mantenevano intatte le partecipazioni non solo dello Stato ma anche degli enti locali. In Francia, quando un’attività è ritenuta strategica, i governi non abbandonano le imprese in crisi e i sindacati accettano sacrifici per ottimizzare le economie di scala. A parte le “quote” di ripartizione di alcune produzioni, non è mai esistita una legge europea che imponesse di privatizzare, bastava che le imprese pubbliche diventassero competitive.
Perché si è seguita la linea delle privatizzazioni ad oltranza nel silenzio dei partiti e dei sindacati? Per capirlo, bisogna ricordare cosa è stata l’Italia ai tempi dei “fenomeni”, ossia quei gruppi emergenti secondo i quali le pratiche con cui gli imprenditori ottenevano le commesse delle imprese pubbliche, l’evasione fiscale e la corruzione di pubblici funzionari, sarebbero state la conseguenza delle scelte scellerate di un pugno di vecchi politici e che bastasse sostituirli per rinnovare il sistema.
Bisogna subito ricordare i “fenomeni” in Magistratura che, sotto le mentite spoglie dell’”indipendenza”, volevano rivoltare l’Italia come un calzino. Personaggi caduti nell’oblio, alcuni dei quali hanno fatto una fine ingloriosa. Era accaduto che, mentre la classe politica nata dalla Resistenza aveva amnistiato i crimini dei magistrati sotto il regime fascista (ivi compresi quelli commessi dai giudici dei Tribunali speciali che mandavano al confino gli oppositori), a distanza di pochi decenni, manipoli scelti di “fenomeni” togati erano riusciti a distruggere i partiti della Prima Repubblica che avevano “perdonato” i loro predecessori.
Ci sono stati i “fenomeni” della carta stampata, che scrivevano libri scandalistici nei quali si denunciavano i misfatti della classe dirigente, dimenticando che la categoria meno autorizzta a giudicare era proprio quella che essi rappresentavano: le testate agli ordini di gruppi imprenditoriali che se ne servivano per fare affari e succhiare risorse pubbliche. I giornali possono condizionare i governi (per ottenere privilegi ai loro padroni) ma non sono gli editorialisti a rovesciare i governi. Bisogna essere grati alle rare testate indipendenti, come Blitzquotidiano, che ospitano le voci più autentiche e libere del Paese.
I “fenomeni” dell’anti mafia si facevano passare per eroi, mentre le mafie di tutto il mondo (cinese, albanese, nigeriana, sudamericana) si espandevano a macchia d’olio nei nostri territori, taglieggiando gli abitanti dei quartieri privi di difese.
Eccoci ai “fenomeni” che volevano sostituire i tecnici alla classe politica. Tutte le democrazie occidentali si basano sui partiti. Ogni volta che la reazione cerca di abbattere la democrazia, essa denuncia i partiti, come avevano fatto Mussolini o Hitler e fa ancora Putin che elimina gli oppositori.
La vita reale è più forte dei “fenomeni”, la vita cerca un compromesso tra le idee e la loro applicazione pratica: questa ricerca spetta ai partiti e non ai tecnici. Solo che, con la fine dei partiti organizzati, erano venute meno le radici storiche del pensiero politico. Si verificavano così alleanze spurie per il solo fine del potere.
Ad esempio, come era possibile unire in un solo corpo i cattolici legati ai valori della famiglia tradizionale e le nuove formazioni che volevano distruggerli? Del resto, si affermava, non ci sarebbe più stato bisogno dei partiti, perché tutto si stava riducendo al possesso dei mezzi di persuasione delle masse. Si vendeva la politica come fosse una bibita, gli influencer facevano proseliti e i club degli “arricchiti” monopolizzavano i gangli del potere reale.
Grazie alla loro combinata azione, i “fenomeni” sono riusciti a destabilizzare il paese sul piano etico, come non si è verificato nelle altre nazioni europee alle prese con analoghi problemi, caratteristici dell’epoca protezionista.
Qual è stato il “grimandello” di cui si sono serviti i “fenomeni” del capitalismo nostrano per impadronirsi delle risorse nazionali? Essi hanno affermato che i vecchi “boiardi” erano incapaci di gestire le aziende pubbliche, mentre le stesse aziende, nelle loro mani, avrebbero generato ricchezza diffusa.
I più modesti imprenditori privi di scrupoli si candidavano a guidare l’economia nazionale e chiedevano finanza a tutti i cittadini che si sarebbero a loro volta arricchiti. Tuttavia, i rialzi di borsa iniziali si sarebbero dimostrati una bufala. I “capital gain” finivano nelle tasche delle solite famiglie blasonate, a danno di masse popolari che perdevano i risparmi di una vita. I principali beneficiari delle privatizzazioni, hanno gonfiato i loro patrimoni.
Dinnanzi al dilagare della povertà, il popolo giudica con molte riserve le liti fra gli eredi di una famiglia imprenditoriale torinese, uno dei quali pretende, per la sua sola quota, la cifra di 1,2 miliardi di euro.
Molte aziende alimentari sono finite a francesi e tedeschi. Le banche, le imprese assicurative e farmaceutiche, le telecomunicazioni e quelle ad elevato contenuto tecnologico, sono state acquistate dai fondi internazionali che miravano al business, propiziato da licenziamenti di massa. Non si era considerato che, quando i centri direzionali di una banca sono controllati da gestori esteri, costoro impongono i loro “prodotti”, incamerando così i nostri capitali.
Se un gruppo industriale deve ridurre la produzione, si sacrificano prima gli stabilimenti italiani, come la Mittal indiana ci sta dimostrando. Alla riduzione dell’area produttiva del paese sarebbe seguita la fuga dei cervelli. I livelli dei costi della vita e della fiscalità allargata sono ritenuti insopportabili perfino dal pensionato che si rifugia in paesi a più basso indice di parassitismo.
Gli italiani, grandi inventori e tecnici del passato, hanno perso la propria identità e sono diventati semplici “assemblatori” nella catena di produzione europea; con la conseguenza che il livello dei salari è rimasto immutato negli ultimi trent’anni. E’ inoltre singolare che gli stessi giornali padronali, i quali avevano “santificato” la fase delle privatizzazioni, invochino oggi aiuti pubblici per mantenere in Italia l’industria delle auto, ormai controllata da americani e francesi.
Per quale ragione, durante il ciclo liberista, infinite aziende italiane si sono trasferite all’estero e le stesse aziende estere insediatesi in Italia hanno ridotto la loro presenza nel nostro paese? Le scelte imprenditoriali si basano su criteri di redditività: è dunque evidente che i decisori economici internazionali ritengono vantaggioso insediarsi in Polonia, Ungheria o Romania piuttosto che in Italia. Le imprese che restano nel nostro paese pretendono sussidi pubblici e, dopo averli incassati, avviano licenziamenti senza preavviso. I segretari di partito e i ministri si limitano a dichiarare il proprio stupore.
In conclusione, l’erario versa oggi al privato molto più di quanto pagava un tempo per tenere in vita le partecipazioni statali. Resiste a fatica il settore delle PMI, che è tuttavia messo in crisi dalle moderne “gabelle” relative al passaggio all’economia green, come avviene ad esempio nell’agricoltura. Senza che ce ne accorgessimo, la politica liberista che avrebbe dovuto eliminare l’intervento pubblico in economia, ha finito per trasformare l’Italia in un paese che vive di sussidi statali.
La crisi delle piccole e medie imprese, che producono valore aggiunto anche in funzione della produttività della mano d’opera, dipende dal fatto che l’italiano medio ha abbandonato i mestieri che sono lasciati agli immigrati. Stimo mille volte di più l’immigrato che accetta di fare l’agricoltore, il manovale, l’artigiano, il badante, il cameriere, agli italiani che preferiscono il soldo statale comunque denominato. L’immigrazione fuori controllo è anche il prodotto di una generazione di individui privi di dignità. La carità pubblica distrugge infatti la dignità quando non offre una speranza di riscatto attraverso il lavoro.